Nessun risultato
La pagina richiesta non è stata trovata. Affina la tua ricerca, o utilizza la barra di navigazione qui sopra per trovare il post.
 Nel 1954 la torre del Bargello, costruita nel ’700 sulle fondamenta di un’altra più antica del XII secolo, crollò rovinosamente causando la distruzione di parecchi edifici del centro storico. Fra questi la più grave perdita fu quella della chiesa romanico-gotica della quale solo la facciata e il pronao, a seguito di abili e tempestivi restauri, vennero recuperati mentre la parte restrostante, e cioè l’intera chiesa, andò irrimediabilmente distrutta.
Nel 1954 la torre del Bargello, costruita nel ’700 sulle fondamenta di un’altra più antica del XII secolo, crollò rovinosamente causando la distruzione di parecchi edifici del centro storico. Fra questi la più grave perdita fu quella della chiesa romanico-gotica della quale solo la facciata e il pronao, a seguito di abili e tempestivi restauri, vennero recuperati mentre la parte restrostante, e cioè l’intera chiesa, andò irrimediabilmente distrutta.
Quanto grave fosse la perdita e quanto importante la chiesa quale documento della fase storico-artistica in cui era stata costruita è testimone la facciata, i cui particolari decorativi si presentano come elementi di transizione tra il Romanico ed il Gotico qui riassunti in un grande arcone cieco ad ogiva, entro il quale è un’elegante ed ampia bifora contenuta in un arco a tutto sesto superiormente raccordato alle spalle dell’ogiva.
Sopra l’ingresso, oggi espresso in una grande arcata a sesto ribassato che mette in comunicazione e dà luce ad un ambiente retrostante, che niente ha a che vedere con la navata della chiesa, è al centro un leone, reso ad altorilievo e di ottima fattura, collocato in uno spazio ricavato, a mo’ di edicola, sotto un cornicione di notevole aggetto. Ai lati sono due larghe paraste superiormente concluse con una cornice.
La pagina richiesta non è stata trovata. Affina la tua ricerca, o utilizza la barra di navigazione qui sopra per trovare il post.
 Già adibita ad archivio comunale e biblioteca e gravemente danneggiata dal sisma, è stata di recente restaurata e presenta oggi una sobria ed elegante facciata con portale contenuto entro pilastri quadrati conclusi agli angoli per mezzo di costolature cilindriche certamente in origine ornati alla sommità di sculture, collocate a mo’ di capitelli, con motivi zoomorfi oggi scomparsi. La porta vera e propria, con piedritti ed architrave di forma rettangolare, immette in un interno ad una sola navata, con tetto a capriate e pareti laterali rese scenograficamente vive sino al transetto con motivi architettonici simili a quelli di Santa Maria Maggiore e cioè con archi ciechi, due per lato, su pilastri semiesagonali e capitelli con aggetto non troppo forte. Nella parte destra, entro gli archi, sottarchi su pilastri e mensole. Superiormente mono for e cieche completano la decorazione delle pareti. Due mensole, una a forma di volto demoniaco e l’altra decorata a motivi geometrici, sono poste agli angoli della controfacciata ad ornamento della stessa e a sostegno della prima arcata distesa sulle pareti laterali.
Già adibita ad archivio comunale e biblioteca e gravemente danneggiata dal sisma, è stata di recente restaurata e presenta oggi una sobria ed elegante facciata con portale contenuto entro pilastri quadrati conclusi agli angoli per mezzo di costolature cilindriche certamente in origine ornati alla sommità di sculture, collocate a mo’ di capitelli, con motivi zoomorfi oggi scomparsi. La porta vera e propria, con piedritti ed architrave di forma rettangolare, immette in un interno ad una sola navata, con tetto a capriate e pareti laterali rese scenograficamente vive sino al transetto con motivi architettonici simili a quelli di Santa Maria Maggiore e cioè con archi ciechi, due per lato, su pilastri semiesagonali e capitelli con aggetto non troppo forte. Nella parte destra, entro gli archi, sottarchi su pilastri e mensole. Superiormente mono for e cieche completano la decorazione delle pareti. Due mensole, una a forma di volto demoniaco e l’altra decorata a motivi geometrici, sono poste agli angoli della controfacciata ad ornamento della stessa e a sostegno della prima arcata distesa sulle pareti laterali.
Il presbiterio, molto elevato (7 gradini), ha le pareti laterali completamente nude mentre nell’abside si aprono due ampie monofore probabilmente non coeve alla costruzione dell’edificio originario che può essere datato verso la fine del XII secolo.
Su gran parte delle pareti della chiesa, specie nel presbiterio oggi architettonicamente così nudo, dovevano essere distesi numerosi affreschi purtroppo perduti ad eccezione di alcuni frammenti fra i quali il più completo, per contenuto narrativo, è la Salita al Calvario di ignoto pittore goticheggiante che interviene in epoca di molto successiva a quella della fondazione della chiesa. Questo quadro, non più collocato al posto originario, è nella seconda arcata della parete di sinistra. Sempre sulla stessa è un piccolo affresco con la figura di San Giovanni Battista, di ignoto autore, molto venerato dai fedeli. Nella seconda arcata di destra due affreschi molto mutili i cui particolari tuttavia parlano di un artista di notevoli capacità disegnative e cromatico il cui stile è caratterizzato da un grosso segno di contorno e da un netto ed elegante disegno delle membra.
Attraverso un ambiente laterale si discende al piano inferiore ove sul filo della fiancata destra della chiesa superiore è un vano con soffitto a botte costruito con blocchi di tufo squadrati e ritenuto da alcuni una primitiva cappella romanica dell’VIII-IX secolo. La volta di quest’ambiente è decorata con affreschi tardo cinquecenteschi ritornati alla luce dopo gli ultimi restauri.
La pagina richiesta non è stata trovata. Affina la tua ricerca, o utilizza la barra di navigazione qui sopra per trovare il post.
 Si affaccia su una piccola piazza e presenta una fronte, in conci squadrati di nenfro che ha il coronamento superiore dentato e la superfice divisa orizzontalmente in due partite per mezzo di una cornice aggettante.
Si affaccia su una piccola piazza e presenta una fronte, in conci squadrati di nenfro che ha il coronamento superiore dentato e la superfice divisa orizzontalmente in due partite per mezzo di una cornice aggettante.
Il portale, con lunetta decorata con affresco del XVI secolo, purtroppo molto guasto, raffigurante la Madonna fra San Silvestro e San Giuseppe, ha — entro due incassi dal ciglio esterno arrotondato — due colonnine tortili con capitelli a motivi vegetali stilizzati ed una cornice interna bugnata. Sopra il portale, nella partita superiore, è un oculo privo di raggi e con ghiera dentata. Delle fiancate esterne è oggi visibile solo quella destra, in conci di tufo squadrati, poiché a quella sinistra si sono addossate costruzioni recenti.
L’interno, sino a poco tempo fa molto alterato per una recente ristrutturazione che aveva ridotto le antiche quattro navate a due, si presenta attualmente, a seguito dei restauri successivi al sisma, completamente libero dalle pesanti infrastrutture ed imponente per una navata che gli conferisce spazialità e monumentalità.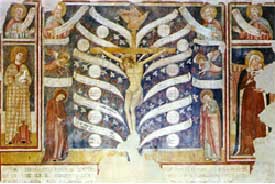
Per quanto riguarda l’abside, questa doveva in origine essere addossata al primitivo muro terminale che fungeva anche da raccordo fra le mura castellane ed il campanile, realizzato con una struttura esterna analoga a quella della facciata della chiesa, che ha la sua altezza divisa in tre comparti da due cornici in aggetto e conclusa in alto con una cornice a fiori stilizzati. La sommità è alleggerita da bifore, scandite in profondità da tre colonnine, elementi struttivi questi assai interessanti che trovano confronto nel campanile di San Silvestro ad Acquapendente ed in torri campanarie della Borgogna.
La pagina richiesta non è stata trovata. Affina la tua ricerca, o utilizza la barra di navigazione qui sopra per trovare il post.
 Consacrata nel 1333, fu completamente ristrutturata nel 1838 secondo quanto documentato nel preventivo di restauro conservato negli archivi della chiesa stessa e nel progetto relativo, che mostra le strutture della chiesa più antica e le modifiche da apportare. In seguito ai crolli del sisma del 1971 molti elementi struttivi e decorativi della più antica chiesa sono tornati alla luce e posti, grazie ai recenti restauri, in evidenza restituendoci così tracce molto precise della primitiva costruzione romanica.
Consacrata nel 1333, fu completamente ristrutturata nel 1838 secondo quanto documentato nel preventivo di restauro conservato negli archivi della chiesa stessa e nel progetto relativo, che mostra le strutture della chiesa più antica e le modifiche da apportare. In seguito ai crolli del sisma del 1971 molti elementi struttivi e decorativi della più antica chiesa sono tornati alla luce e posti, grazie ai recenti restauri, in evidenza restituendoci così tracce molto precise della primitiva costruzione romanica.
La facciata, decorata con un portale arricchito di colonnine tortili, assai simile a quella di San Silvestro, ha lunetta decorata con un affresco con raffigurazione di Madonna con Bambino e Santi del XVI secolo, mentre la superiore rosa — di forma ottagonale di realizzazione molto modesta — sembra, secondo il progetto ricordato, essere attualmente più bassa rispetto alla sua collocazione originaria.
L’interno, ad una navata, ha soffitto ligneo e capriate sostenute da arconi ad ogiva su alto piedritto con mensole. In quanto alla profondità della navata, oggi forse ridotta, una muratura in blocchi di tufo ad andamento curvilineo, evidente in un ambiente collocato sul retro del muro terminale con il quale oggi si conclude la chiesa, è forse indizio di un’abside che sembra ribassata rispetto al piano dell’attuale chiesa. Sulla parete di fondo, a destra dell’abside, è un piccolo ciborio goticheggiante.
Nella controfacciata, in una nicchia a sinistra del portale, alcuni affreschi trecenteschi fra cui una Annunciazione, un Santo Vescovo, Madonna con Bambino e, in alto, Padre Eterno ed Angeli.
Dietro l’altare maggiore, entro una grande nicchia ricavata nel muro divisorio pertinente alla ristrutturazione del 1838, è un crocifisso ligneo quattrocentesco proveniente dalla chiesa di Santa Maria del Riposo, qui in deposito temporaneo; sulla destra avanzi di affreschi quattrocenteschi. Di recente restauro è l’organo seicentesco collocato a destra dell’altare maggiore.
La pagina richiesta non è stata trovata. Affina la tua ricerca, o utilizza la barra di navigazione qui sopra per trovare il post.

Chiesa di S. Agostino Tuscania
LA CHIESA ED IL CONVENTO DI S. AGOSTINO A TUSCANIA
di Giuseppe Giontella
La notizia più antica che attesta la presenza a Tuscania dei frati dell’Ordine degli Eremitani di S. Agostino nell’omonimo convento è del 1275. I frati dovevano essere abbastanza numerosi ed erano diretti da un Padre Priore. Conosciamo il nome di un Padre Priore soltanto nel gennaio del 1393: si tratta di Frate Egidio da Corneto, che difese in tribunale alcune prerogative usurpate ai frati del suo convento.
Dalla lettura dei documenti d’Archivio, risulta che gli Agostiniani furono sempre benvoluti dalla popolazione di Tuscania: fin dal 1313 troviamo una devota tuscanese, donna Guidetta vedova di Gezzo Falchi, che, per la salvezza dell’anima, istituisce un legato testamentario destinato a finanziare alcuni lavori di ristrutturazione della chiesa di S. Agostino non specificati nei dettagli. Un altro legato testamentario, del 1348, è devoluto alla Cappella della Confraternita dei Disciplinati di S. Agostino, che, nel 1523, venne trasferita da S. Agostino nella Chiesa di S. Maria della Rosa, dove cambiò divenendo la Confraternita del Gon

falone.
I fedeli vollero ricostituire altre due Confraternite: quella dei “Centuriati di Santa Monica” (in onore della madre di S. Agostino) e quella della “Madonna del Carmine”, che furono attive per diverso tempo. Troviamo i “fratelli” di queste due Confraternite andare in processione ancora nel 1704.
Nonostante le proprietà immobiliari, spesso le entrate non riuscivano a fronteggiare le spese per i lavori straordinari di manutenzione della chiesa e del convento. Gli archivi tuscanesi conservano testimonianze della generosità sia del Comune che di privati cittadini: numerosissimi sono (oltre a quelli citati) i legati testamentari istituiti a favore degli Agostiniani lungo il corso dei secoli, fino alla fine del Settecento, soprattutto da parte di quei cittadini che desideravano essere sepolti a S. Agostino.
Anche nelle deliberazioni del Consiglio comunale si trovano molte notizie di sovvenzioni in denaro o in beni (legna, carne, pane, ecc.) concessi dal Comune per lavori di consolidamento e di restauro.
Gli Agostiniani han
no abitato il Convento e officiato la chiesa per oltre cinquecento anni, dal XIII secolo al 1798, quando vennero espul
si dall’invasione francese che dette vita alla Prima Repubblica Romana.
LA CHIESA
Gli elementi architettonici della primitiva chiesa romanica a navata unica sono ridotti a poca cosa, come le cappelle laterali a nicchione, ricavate nello spessore del muro e le finestre a strombo con arco a tutto sesto, che scandivano le pareti; così pure sono testimoni di questa prima costruzione la parte absidale esterna, dove restano masselli di tufo a fil di muro, e buona parte delle murature perimetrali, in conci quadrati di tufo.
Alle forme romaniche si sovrappose la ristrutturazione nel XIV secolo, in cui dominano gli elementi gotici, come lo snello finestrone a sesto acuto, che si affaccia su Piazza Italia, dal quale si irradia la luce nel presbiterio (originariamente era una bifora di cui rimane solo un frammento della colonnina centrale), le mensole laterali dalle quali spiccavano gli arconi della volta, poi completamente trasformata e l’arco trionfale a sesto acuto slanciato, squisitamente gotico.Il volume della chiesa, poi, era scandito da arconi ogivali di sostegno (rimangono solo alcune tracce), simili a quelli che si possono ancora ammirare nelle locali Chiese trecentesche di S. Silvestro, S. Biagio e S. Marco.
Qualche traccia di affresco tre-quattrocentesco si trova nel presbiterio (a sinistra del finestrone): si vedono solo due santi che affiancano una figura centrale scomparsa. Anche nella navata di sinistra (dopo la seconda cappella a nicchione) si possono ammirare i resti di una Natività di buona fattura. Vi sono altri frammenti di affreschi, ma ormai scarsamente leggibili.
Sotto il primo altare di sinistra di gusto barocco, dopo il terremoto è emerso un affresco rinascimentale che ornava il precedente altare: si nota la figura di un santo agostiniano su cui si legge la scritta: IN TRIBULATIONE EXUDIAM EUM.
La chiesa ricevette una qualificazione stilistica nella seconda metà del Quattrocento, quando venne aperta la cosiddetta “loggia” nella parete di destra, forse una cappella, di cui resta un soprarco di monofora laterale con decorazione trilobata e circolo centrale.
Ma la ristrutturazione più notevole di questo periodo si deve all’iniziativa di un noto esponente della nobiltà tuscanese, il prelato Paolo Ludovisi, avvocato presso la Sacra Rota, che volle aprire, sempre sulla parete destra, una sontuosa cappella.
L’ apertura della “loggia” e della cappella sconvolsero un po’ tutta la parete destra: alcune finestre a strombo vennero chiuse, come pure due altari a nicchione vennero demoliti. Paolo Ludovisi volle dedicare a S. Giobbe la sua nuova cappella, lasciandone testimonianza con un’epigrafe scolpita sull’architrave d’ingresso:
REVERENDUS PATER DOMINUS PAULUS DE LUDOVISIS DE TUSCANELLA IURIS UTRIUSQUE DOCTOR SACRI APOSTOLICI PALATI CAUSARUM AVOCATUS HOC SACELLUM DIVI IOBI DICATUM FIERI IUSSIT MCCCCLXXXVI.

Il 1486 è, quindi, la data di inizio della costruzione della cappella di S. Giobbe, i cui elementi caratterizzanti sono diversi. Si nota anzitutto il solenne grande arco di nenfro a tutto sesto e terminazione orizzontale: è interamente scolpito con bassorilievi raffiguranti candelabri, festoni e putti, oltre all’iscrizione citata: certamente lo scultore doveva conoscere molto bene gli stucchi delle “grottesche” della Domus Aurea romana venuti alla luce e ripresi, proprio in quegli anni, ad opera del Ghirlandaio e del Pinturicchio.
All’interno della cappella si apre il catino absidale, anch’esso incorniciato da un arco di nenfro ornato. Nel vano del catino c’era l’altare con il tabernacolo (oggi scomparsi), sopra al quale si può ancora ammirare il pregevole affresco della Crocifissione, attribuita alla scuola viterbese della fine del Quattrocento: il pittore ha rappresentato al centro il Cristo crocifisso ormai morto, con tre angeli che raccolgono in tre calici il suo sangue zampillante dalle mani e dal costato; sotto la croce, oltre alla Madonna (a sinistra) e a S. Giovanni Evangelista (a destra), assistono alla scena anche i membri della committenza: i nobili Ludovisi, sia maschi che femmine. il cartiglio sottostante l’affresco è redatto in volgare: ADI’ 7 DE MAGIO .M.CCCC.LXXXXII, ma è di fattura posteriore. Al centro della volta è collocato, a rilievo in stucco colorato, lo stemma di una famiglia seicentesca che ebbe il giuspatronato successivamente alla famiglia Ludovisi.
Sulle pareti laterali della cappella si aprivano due finestroni a strombo con arco a tutto sesto: quello di destra fu poi chiuso; quello di sinistra venne ridotto a finestra quadrata. Nella parete di destra è incastonato un tabernacolo cinquecentesco in nenfro, in prossimità del quale si trova un confessionale settecentesco in noce.
La chiesa fu nuovamente consacrata l’8 ottobre 1566, come si leggeva in una tavoletta “appesa dietro l’altare maggiore”, riportata nella visita pastorale del 1881 effettuata dal vescovo Paolucci: “Anno Domini MDLXVI die VIII octobris consecrata fuit haec ecclesia S. Agustini”.
Nei secoli successivi ebbe il patronato famiglia dei Conti Pocci, i cui membri, in particolare i due fratelli, il Conte Cesare (1810-1875) ed il Conte Mariotto (1813-1881): lo hanno conservato fino all’unità d’Italia.
Tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento era Priore del convento il Padre baccelliere Fulgenzio Pocci “Patrizio Tuscanese” (n. 1653 – † post 1710): egli fece ristrutturare a sue spese la chiesa (rimangono gli altari bianchi), poi restaurò ed arredò una parte del convento per l’accoglienza dei visitatori, dotandola anche con ricchi ornamenti ed arredi.
Questi restauri settecenteschi voluti da Padre Fulgenzio Pocci furono radicali: erano già precedentemente scomparsi i finestroni a strombo che si aprivano sulla parete di sinistra già al tempo della costruzione del convento. Venivano tamponate tutte le cappelle a nicchione per far posto ai sei altari (tre a destra e tre a sinistra) di gusto barocco, in pietra e stucco. Così pure scomparivano gli arconi ogivali gotici, mentre il tetto veniva realizzato a capriate. Fu certamente Padre Fulgenzio a far riprodurre gli stemmi della sua famiglia in cinque dei sei altari. Suo fratello Francesco Pocci (1654-18.08.1726), nel 1725, fece collocare l’epigrafe in marmo sulla parete di sinistra (ora spostata nella controfacciata, sotto la cantoria) per commemorare la recente morte del figlio Fabrizio (†17.8.1725) e di un altro suo fratello, Piergiovanni (†15.06.1724), ma anche con l’intento di celebrare l’antichità della sua famiglia, romana di origine, tuscanese per adozione, che a Tuscania fu sempre una tra le più cospicue, insieme a quella dei Fani, dei Giannotti e dei Ciglioni[1].
L’altare maggiore venne spostato in avanti, sotto l’arco trionfale gotico, e ricreato con un nuovo scenario barocco incastonato in un nuova cornice, terminante in un arco a tutto sesto, mentre l’abside divenne la sacrestia. Nelle pareti laterali si vedono ancora le due porte: a sinistra si ha l’accesso al chiostro, a destra si va nella “loggia”, di cui restano oggi solo alcune tracce evidenti in pietra e qualche residuo di affresco.
All’ingresso della chiesa, sulla destra, esisteva una Madonna in terracotta di buona fattura, donata nel 1708 dal canonico Bartolomeo Bonsignori: rappresentava la “Maternità di Maria Santissima”. Oggi rimane solo la preghiera, che il Bonsignori vi fece apporre in forma epigrafica (la Madonna è stata rubata diversi anni fa):
(SN) NOS CUM PROLE PIA (SN)
BENEDICAT ET LIBERET A PECCATIS, IMPROVISA MORTE,
FULGURE, TEMPESTATE, TERRAEMOTU, PESTE, FAME, BELLO,
IRA, ODIO, MORTE PERPETUA ET OMNI MALO
FILIA SPONSA MATER VIRGO MARIA
IMPLORAT HUMILLIME
CANONICUS BARTHOLOMAEUS BONSIGNORIUS *
1708
Anche la facciata della chiesa venne completamente rifatta: ora si presenta austera e semplice, con portale e finestra a cornici in pietra modanate, e con pinnacoli e basi superiori per statue, oggi scomparse (o mai collocate). Un semplice e tardo campanile a vela con due campane, venne collocato sul lato destro del tetto, sopra la cappella Ludovisi.
Nella citata visita pastorale del 1881 (vescovo Paolucci) si legge che nella chiesa vi sono sette altari:
– l’altar maggiore sotto l’invocazione della Madonna SS. Del Popolo;
– a destra (a partire dall’ingresso) vi sono tre altari: il primo dedicato a S. Nicola da Tolentino, il secondo al SS. Crocifisso (Cappella Ludovisi, successivamente la famiglia Bassi ne ebbe il giuspatronato), il terzo è dedicato a S. Agostino e a S. Monica.
– anche a sinistra (a partire dall’ingresso) vi sono tre altari: il primo dedicato a S. Tommaso da Villanova, il secondo alla Natività di Nostro Signor Gesù Cristo, il terzo a S. Gaetano da Thiene.
“In tutti gli altari vi sono quadri in tela, ad eccezione dell’altare maggiore in tavola di antica e stimata pittura et il Crocifisso in muro di pittura antica e di qualche pregio creduta”.
Allo stato attuale la chiesa, riparata e restaurata negli anni ’70 del Novecento, in seguito ai danni provocati dal sisma del 1971, si presenta come un vasto ambiente, spoglio di molti dei suoi elementi decorativi (in buona parte trasferiti altrove), ma ancora ricca di decorazioni e arredi, altari e cappelle, che ne restituiscono bene la storia e l’integrità, nonché la possibile funzionalità, mantenendo tutta l’importanza di luogo sacro e monumento pubblico di Tuscania, dove i diversi stili che si sono succeduti, il romanico, il gotico, il rinascimentale ed il barocco, sono stati armoniosamente evidenziati in modo da rendere più agevole la lettura dello sviluppo del tessuto architettonico lungo il corso dei secoli.
Dal 1903 al 1970 questa chiesa è stata sempre considerata come la chiesa dei giovani, perché in essa i ragazzi ricevevano la Prima Comunione, dopo tre giorni di ritiro spirituale, organizzato e diretto dal benemerito Conte Enrico Avv. Pocci, poi dai suoi due figli, di buona memoria: l’Ingegnere Fabrizio Pocci e Mons. Filippo Pocci, vescovo titolare di Gerico ed ausiliare per la diocesi di Roma.
Attualmente la chiesa è inagibile e chiusa al pubblico: dopo il terremoto, ciò che aveva di artistico è stato trasportato in altra sede, come la pregevole tavola dell’Altare Maggiore, rappresentate la “Madonna dei Raccomandati” conosciuto anticamente con il nome di “Madonna del Carmine”, come abbiamo già vistto, o come “Madonna del Popolo” , unica opera del pittore viterbese Valentino Pica, realizzata poco dopo il 1466. E’ una tavola dipinta su due lati: in quello posteriore (verso la sacrestia) è raffigutrato S. Nicola da Tolentino, mentre in quello anteriore “…si rimira – scriveva l’arciprete don Giuseppe Di Lorenzo – quella vivacità d’immagini che non si riscontra nelle opere delle epoche che furono innanzi. E’ quivi dipinta Nostra Signora che, con ambe le braccia, stende l’ampio suo manto sotto del quale è ricoverato il popolo cristiano, riparato dai roventi fulmini che scaglia dall’alto l’eterno padre, terribile nell’aspetto. Parte di essi si arresta sul manto di Nostra Signora, gli altri colpiscono a morte coloro cui non toccò la ventura di cessare il castigo sotto l’usbergo del patrocinio di Maria. E’ assai ben espresso il popolo cristiano nelle figure che si vedono sotto il manto della Vergine, distinte in gerarchie, gradi e condizioni, perché vi sono papi, cardinali, vescovi, religiosi e religiose, magistrati, nobili e plebei, ciascuno coll’abito proprio della sua condizione e nel vero costume del tempo nel quale fu condotta tal pittura”.
Nella sacrestia si conservava un quadro con il volto del Redentore, che “nella tecnica e nell’espressione si rivela dell’epoca bizantina, tranne la fascia inferiore”.
Per motivi di sicurezza la tavola è stata trasferita altrove, mentre il quadro con il volto del Redentore si trova presso il palazzo vescovile di Viterbo.
La cantoria, posta sopra l’ingesso principale è stata utilizata fino al terremoto, ma subito dopo l’organo settecentesco è stato portato nella chiesa parrocchiale di S. Marco.
IL CONVENTO
Come abbiamo già accennato, con l’occupazione dei Francesi del 1798 arrivò anche la soppressione dei Conventi. Gli Agostiniani di Tuscania, il 21 aprile 1799, vennero trasferiti a Corneto, presso i loro confratelli del convento di S. Marco (attuale sede della Scuola Media “E. Sacconi”) e non fecero mai più ritorno a Tuscania.
Poco tempo dopo la fine dell’Impero Napoleonico, nel 1816, il vescovo di Viterbo e Tuscania, Card. Severoli, d’accordo con la Santa Sede e l’Ordine degli Agostiniani, istituì il seminario nei locali dell’ex-convento di S. Agostino che, dopo l’unità d’Italia, ospitò anche alcune classi delle scuole elementari.
Durante la Prima Guerra Mondiale, alcuni locali del seminario di S. Agostino furono utilizzati anche come laboratorio per la manifattura di fasce, passamontagna e guanti di lana destinati ai soldati che combattevano al fronte: dirigeva il laboratorio un’inviata dagli Stati Uniti d’America, Miss Ada Martin, coadiuvata da numerose operaie ragazze di Tuscania.
Finita la Grande Guerra, oltre al seminario continuarono a convivere insieme anche alcune classi delle elementari: la prima e la quarta maschili al piano superiore (in una stanza dentro l’altra!), mentre la classe terza era ospitata al primo terreno. Anche le aule scolastiche dei seminaristi, la cucina ed il refettorio erano al piano terreno, mentre i loro dormitori si trovavano al primo piano.
Nel seminario vennero, poi, predisposte due nuove aule per le classi settima ed ottava elementare, che non entrarono mai in funzione.
Il seminario fu chiuso definitivamente nel 1928 (i seminaristi furono trasferiti a Viterbo), ma dopo appena qualche anno l’ex convento degli Agostiniani divenne il ricovero provvisorio degli sfollati della Seconda Guerra Mondiale. Da provvisorio, il ricovero divenne definitivo, fino a quando gli sfollati non furono trasferito in seguito al terremoto del 1971.
Non sappiano quale aspetto avesse il convento con le sue celle nel suo interno. Nel 1818 fu completamente ristrutturato, quando venne trasformato in seminario. Nemmeno questa nuova struttura oggi è possibile leggere, a causa delle trasformazioni subite ad opera degli sfollati, ma, soprattutto, del terremoto.
Soltanto il chiostro conserva aspetti originari.
Di stile rinascimentale, esso è ancora in grado di invitare il visitatore al silenzio ed alla meditazione.
Ciascun lato dell’ampio quadrato è delimitato da cinque arcate a tutto sesto, sorrette da tozze colonne poggianti su uno spesso muro, ma l’insieme non è per nulla appesantito; anzi, la teoria delle venti colonne si snoda agilmente lungo tutto il perimetro.
Su ciascun prospetto di tre delle quattro pareti si aprono quattro severe finestre rettangolari con cornice in nenfro per dar luce agli ambienti del primo piano: si interrompe così la monotonia dei muri; e lo sguardo d’insieme è reso ancor più suggestivo dalla parete nord, sulle cui cinque arcate, in luogo delle finestre, si apre un’elegante loggetta con balaustra, scandita da colonnine quadrate collegate da archetti a sesto ribassato: in tal modo l’architetto è riuscito a rendere molto più snelli i diversi volumi con l’alternarsi di pieni e vuoti dell’ambiente claustrale.
Sia al centro della parete nord che in quella sud era dipinta una meridiana, con lo gnomone in ferro, ma ambedue le meridiane sono scomparse in seguito all’eliminazione dell’intonaco, avvenuta con i restauri successivi al terremoto. Così pure sono andate perdute le epigrafi dipinte in nero sull’intonaco delle pareti del chiostro: esse ricordavano la trasformazione del convento in seminario. E’ certamente possibile il loro rifacimento sia perché vi sono numerose fotografie, scattate lungo il corso del XX secolo, sia perché sono state tutte pubblicate da Celestino Masetti, Sulla vita e sulle opere del card. Antonio Gabriele Severoli – Commentario storico, in “l’Album”, vol. XX (Roma 1853), p. 3:
PIO VII P. M.
PATRONO LITERARUM AUCTORI SUO
SEMINARIUM THUSCANIENSE
A. MDCCCXVI IV. EID. NOV.
QUO DIE DEDICATUM EST
***
ANTONIO GABRIELI SEVEROLIO
CARD. PONT. THUSCANIENSIUM ET VITERBIENSIUM
QUOD PER EUM
AEDES CUM TEMPLO
FF. AUGUSTINIENSIUM
IN NOVISSIMA ORBIS TURBATIONE PUBLICATAE
D. N. PII VII RESCRIPTO
IN PATRIMONIUM THUSCANICAE PUBIS
BONIS ARTIBUS ERUDIENDAE
SUNT REDACTAE
S. P. Q. T. A. MDCCCXVI
***
FRANCISCO ANTONIO TURRIOZZI
ANTIST. THUSCANIEN. XXIV. PER ANNOS
VICARIO
QUEM OMNES BONI CONSENTIUNT
AMANTISSIMUM PATRIAE SUAE FUISSE VIRUM
EIQUE PRAESTITISSE PLURIMA
EDITIS LIBRIS CONSILIO OPE GRATIA
CURA PRAESERTIM SEMINARII
INSTITUENDI ORNANDI PERFICIUNDI
S. P. Q. T. VIV. P.
A. MDCCCXVI
***
QUOD III. VIRI MUN. THUSCANIEN.
S. P. Q. T. ROGARUNT
VELLENT IUBERENT UTI EX AERARIO
NUMM. ARG. CCCCL QUOTANNIS PENDANTUR
REI LITERARIAE SUBSIDIO
QUODQ. S. P. Q. T. JURE SCIVIT
UTI III. VIRI ROGARUNT
VI. VIRI SEMINARII CURATORES
M. P.
QUO MAGIS INTELLIGANT STUDIOSI ADOLESCENTES
QUANTUM PRAESTARE DEBEANT CIVIBUS UNIVERSIS
FIDE IN PATRIAM ET CHARITATE
A. MDCCCXVI
[1] Ecco il testo dell’epigrafe:
D. O. M.
PETROIOHANNI ET FABRICIO DE POCCIS
NOBILIBUS TUSCANENSIBUS
QUI
AB EXIMIO STRENUOQUE VIRO
MARCO POCCIO
ROMAE A. D. MCCCCXXII DEGENTE
COMITE PALATINO ROMANOQUE CIVE
ORIUNDI
OMNEM LAUDEM NON IN GENERIS NOBILITATE
SED IN MAGNIFICENTIA ERGA PAUPERES IN CHRISTIANA
HUMILITATE ATQUE IN UNA DEMUM VIRTUTE
CONSTITUERE
QUORUM MORTALES EXUVIAE
HIC CENSORIUM EXPECTANT DIEM
FRANCISCUS POCCIUS
FRATRI ET FILIO DULCISSIMIS
SIBIQUE VIVENS ET SUIS
POSUIT
ANNO REPARATAE SALUTIS MDCCXXV
La pagina richiesta non è stata trovata. Affina la tua ricerca, o utilizza la barra di navigazione qui sopra per trovare il post.
 Le numerose chiese e i vari conventi dei diversi ordini che punteggiano il tessuto urbanistico di Tuscania, dentro e fuori le mura urbiche, documentano la rilevanza politica e sociale della città che cerca di resistere all’affermazione della vicina Viterbo con la quale dalla fine del XII secolo condivideva la dignità di sede di diocesi.
Le numerose chiese e i vari conventi dei diversi ordini che punteggiano il tessuto urbanistico di Tuscania, dentro e fuori le mura urbiche, documentano la rilevanza politica e sociale della città che cerca di resistere all’affermazione della vicina Viterbo con la quale dalla fine del XII secolo condivideva la dignità di sede di diocesi.
Tra queste fondazioni subito dopo le basiliche di S. Pietro e S. Maria Maggiore, riveste un ruolo di grande rilevanza il complesso ecclesiale di S. Maria della Rosa. Questa con la definitiva decadenza del quartiere di S. Pietro che, già escluso dal perimetro delle mura urbiche, era andato progressivamente spopolandosi finendo definitivamente deserto dopo il sacco operato dalle truppe di Carlo VIII nel 1495 (il Comune esentava dalle tasse quei cittadini che accettavano di vivere nel quartiere, l’offerta rimase però pressoché priva di riscontro e così la città si articolerà nei secoli a venire in terzieri), venne eretta alla dignità di chiesa cattedrale.
Esterno: L’attuale edificio si presenta come il frutto di una serie di rifacimenti e ampliamenti successivi che si evidenziano nelle dissemetrie della pianta, nelle cesure tra i diversi corpi visibili nella facciata e nel sincretismo stilistico che vede elementi gotici inserirsi su un lessico ancora romanico.
 Peculiare è la terminazione rettilinea della facciata che conosce una notevole diffusione a Tuscania nel XIV secolo (S. Silvestro, S. Marco. Madonna dell’Olivo, S. Francesco) articolazione rispettata per omogeneità anche nei due corpi laterali eretti in corrispondenza delle navate laterali che furono aggiunti in momenti diversi.
Peculiare è la terminazione rettilinea della facciata che conosce una notevole diffusione a Tuscania nel XIV secolo (S. Silvestro, S. Marco. Madonna dell’Olivo, S. Francesco) articolazione rispettata per omogeneità anche nei due corpi laterali eretti in corrispondenza delle navate laterali che furono aggiunti in momenti diversi.
Essa è realizzata in conci di pietra vulcanica locale (nenfro) e trova concorde la critica specialistica nella individuazione di elementi topologici che la accomunano a modelli umbri e abruzzesi; una cornice a dentelli la corona in alto mentre due cornici marcapiano suddividono la facciata in tre diversi campi: quello superiore è aperto da un elegante rosone raggiato -ai lati del rosone un restauro degli anni sessanta aveva portato alla tamponatura di due bifore goticheggianti-; l’intermedio, di più ridotte dimensioni, ha un semplice oculo nel corpo sinistro, eccentrico rispetto al portale, e un elegante rosoncino inscritto in una cornice quadrata posto al sommo del portale sul lato destro, quest’ultimo di forte stile gotico; nel registro inferiore si aprono i tre portali caratterizzati da notevoli difformità formali: semplice quello di sinistra, composto di montanti in conci che sostengono una architrave liscia sormontata da una lunetta profilata nello spigolo dell’intradosso da semplice decorazione dentellata; più ricercato il portalino di destra che ha la lunetta ad ogiva ornata da un motivo ad archi trilobi che ripropongono il puro gusto gotico; il portale centrale presenta una strombatura poco profonda formata da due rientranze progressive dove sono alloggiate coppie di colonnine tortili, la sovrastante lunetta riprende la profondità dello strombo con una serie di cornici a profili multipli, gli spigoli dei montanti sono decorati da un fine motivo a punta di diamante.
Il campo della lunetta presenta ancora un affresco seicentesco dove è appena leggibile l’immagine della Vergine tra santi. Sul lato destro della facciata si erge il campanile che si presenta eccessivamente tozzo per la troncatura in altezza di almeno due piani, il piano che sormonta la chiesa è aperto da bifore sui quattro lati (secondo il modello ricorrente i piani superiori dovevano essere alleggeriti con l’apertura di una serie di trifore e, al piano più alto, di quadrifore.
Interno: Le dissemetrie icnografiche evidenziate nella articolazione dei muri esterni si ripetono anche nella organizzazione degli spazi interni. La chiesa è suddivisa in tre navate da due file di quattro colonne che ricevono la ricaduta di archi a tutto sesto con il profilo ornato da dentelli.
 La mancanza di studi specifici rende molto difficile proporre una datazione precisa che la tipologia dei capitelli e resti di affreschi collocano nel XIV secolo.
La mancanza di studi specifici rende molto difficile proporre una datazione precisa che la tipologia dei capitelli e resti di affreschi collocano nel XIV secolo.
I radicali restauri seguiti al sisma del 1971, improntati ad un malinteso purismo medievista, hanno in gran parte cancellato le sovrapposizioni barocche – Cerasa ci documenta come il transetto fosse a terminazione rettilinea e con tre “altaroni” barocchi- che documentavano la storia della chiesa e hanno posto in luce una serie di strutture preesistenti nella zona presbiteriale addossata alla cinta muraria cittadina.
Tali avanzi consistono in un ambiente absidato limitato anteriormente da resti emergenti che alcune fonti interpretano come una antica porta urbica cui fu addossato un edificio sacro; gli elementi a disposizione permettono solo di riconoscere i resti di un edificio sacro ornato da resti di affreschi tra cui una Madonna in trono col Bambino -le scalpellature sulla superficie testimoniano che a questi affreschi ne erano stati sovrapposti altri andati perduti- databile al Trecento.
Nello stesso ambiente, ad un livello superiore, si trovava anche la Madonna col Bambino tra s. Pietro e s. Secondiano conosciuta sotto il titolo di Madonna Liberatrice in seguito al miracolo dello scampato pericolo del 1495; tale affresco staccato, restaurato e ricollocato in situ risponde ad una mano totalmente diversa ai precedenti ma, nonostante l’evidente arcaismo formale, è anch’esso databile ai primi anni del trecento grazie alla analisi delle scritte con i nomi dei santi realizzati in una perfetta onciale gotica che conosce il suo sviluppo proprio sullo scorcio del XIII secolo e nei primi anni del secolo seguente.
La estemporaneità formale della zona presbiteriale è accentuata anche dalla grande cappella sul lato sinistro che si propone quasi come un corpo separato: questo ambiente fu realizzato nella seconda metà del XV secolo per volontà del Comune che intendeva utilizzarla come cappella per conservare le reliquie dei santi martiri protettori conservati nella chiesa di S. Pietro, ormai eccentrica alla cerchia urbana e in un quartiere totalmente disabitato; la cappella fu realizzata ma il trasferimento delle reliquie avvenne solo nel 1612 e a favore della collegiata di S. Lorenzo.
In origine le pareti e le colonne della chiesa erano completamente rivestite di pitture, dopo il succitato terremoto alcuni frammenti superstiti sono ritornati alla luce: una frammentaria immagine di S. Giovanni Battista e dell’Arcangelo Michele sulla seconda colonna di sinistra, databile al pieno Trecento, e i resti di un affresco votivo sulla parete destra dove è ancora perfettamente leggibile l’arme araldica di Angelo da Lavello, detto Il Tartaglia, potestà di Tuscania nella prima metà del Quattrocento.
L’arredo decorativo della chiesa si compone anche di una acquasantiera realizzata con un capitello romanico; una edicola sulla parete sinistra di raffinata fattura antiquariale databile ai primi anni del Cinquecento e, sempre su questa parete, il fastigio di arco, anch’esso nello stile classico antiquariale con decorazioni a candelabre e a motivi floreali così di moda tra il Quattrocento e i primi decenni del Cinquecento, il manufatto funzionale alla apertura di una cappella dedicata a s. Rocco -in seguito tamponata- fu commissionato da un patrizio tuscanese, Secondiano Ciotti, sull’arco compare la data con la dedicazione: SECONDIANUS CIOTTUS DIVO ROCHO DICAVIT MCCCCCVI.
Attualmente sul campo definito dal suddetto arcone è collocata una pala d’altare di buona fattura con la Madonna del Rosario e i quindici misteri, in basso compare una lunga iscrizione in cui è possibile leggere la data ANNO D(omi)NI MDLXIX.
Nel transetto oltre ai mediocrissimi affreschi seicenteschi con la Madonna e santi che ornano l’absidiola di sinistra, rimane sulla parete sinistra il grande altare barocco commissionato dalla famiglia Mansanti con la pregevolissima tela con la Trinità, la Vergine, le anime purganti e santi, nel sordino dell’altare è dipinta una scena con la celebrazione eucaristica, tale complesso decorativo è databile ai primi anni del Settecento.
L’arredo decorativo interno è completato dalla bellissima tela seicentesca con il Martirio di s. Lucia, pertinente all’antico altare di S. Lucia collocato sulla parete sinistra; e dal grande polittico posto nella cappella sulla destra del transetto, opera realizzata nel 1580/81 da Giulio Perino d’Amelia; il polittico si presenta attualmente gravemente menomato dall’asportazione furtiva delle tavole principali, si conserva solo la sua monumentale carpenteria lignea (cm. 320×300) e le scenette della predella con storie della Vergine: Incontro di s. Anna e Gioacchino, Nascita della Vergine, Sogno di s. Giuseppe, Sposalizio della Vergine, Nascita di Gesù, Adorazione dei magi e fuga in Egitto, Disputa con i dottori.
La pagina richiesta non è stata trovata. Affina la tua ricerca, o utilizza la barra di navigazione qui sopra per trovare il post.